C’erano due squadre. Sempre. Fossimo in sei (tre contro tre) in otto, o anche in numero dispari. La conta toccava di solito ai due più bravi. O a chi portava il pallone. Ve lo ricordate il pallone? Prima il Tele, quello che quando tiravi sembrava un piumino del volano e non prendeva mai la strada giusta. Poi arrivò la versione lusso: il super Tele. Un’altra ciofeca pazzesca. Se si giocava in strada con porte di fortuna e un super Tele era più il tempo che si passava a citofonare per farsi aprire il cancello dai malcapitati vicini di casa che per fare la partita. Il pallone più figo si chiamava Super Santos. Praticamente indistruttibile, finisse sotto un tir o una ruspa. Nulla però a che vedere col Tango. Il Tango era l’imitazione del pallone dei mondiali argentini, quelli del ’78, Italia quarta, Zoff battuto da tiri siderali, uno tirato da un certo Josè Guimares Dirceu, che anni dopo sarebbe diventato il mio amigo preferito al Bentegodi, almeno fino a quando gli dissi “Josè, amigo dighelo a to’ pare”. Le squadre venivano fatte così: i due capitani sceglievano un giocatore a testa fino a esaurimento del materiale umano. I parametri usati per la scelta potevano variare. Di solito il primo era il Bomber. Poi il portiere. Nessuno voleva stare in porta, ma col passare degli anni il ruolo subì un’evoluzione. Se da piccoli erano i più brocchi a prendere la desolata via della porta, man mano venne la consapevolezza che avere un buon portiere equivaleva ad avere un buon bomber. Il più bravo di tutti quelli che ho conosciuto si chiamava Mauro detto il “giaguaro” come Castellini. Aveva le braccia lunghe ed una naturale eleganza nel tuffo. Metteva guanti di lana anche ad agosto. Mauro morì a 15 anni, finito col suo motorino sotto un’auto assassina. Per un’ora nel mio paese pensarono che sotto quella macchina ci fossi io e non il giaguaro Mauro.
Il bomber era invece il Caio. Biondo come la pannocchia, era il più piccolo della compagnia. Chi lo aveva si assicurava un infinito bottino di gol e la vittoria certa. Caio,inevitabilmente, finì a giocare nelle giovanili dell’Hellas. Arrivato nella Primavera fece coppia con Nando Gasparini. Una leggenda narra che Caio si sparò ad un piede quando partì per la naja. Non ho mai indagato a fondo se fosse vero. Ma mi piaceva pensarlo. Sarebbe stato un buon motivo per spiegare il suo fallimento calcistico.
Le partite non avevano durata temporale. Erano al “dieci” cioè vinceva chi fosse arrivato prima al dieci. Solitamente erano le mamme che verso le sette di sera mettevano fine alle partite, urlando alla finestra che la cena era pronta e che se non ci fossimo sbrigati a salire, loro avrebbero spreparato e noi non avremmo mangiato. D’inverno era il buio a fermarci, nonostante i tentativi di continuare la partita spostando i campi sotto la fioca luce del neon dei lampioni.
Il calcio era sempre la base di ogni discorso. Vuoi perché c’era da completare l’album, vuoi perché si discuteva su chi fosse il miglior campione da imitare, vuoi perché i papà regalavano sempre dei completini da calcio ai compleanni. Le squadre che andavano di moda erano tre. Juve, Milan, Inter. Il Verona tirava poco. A me regalarono la maglia nerazzurra col 9 di Boninsegna. Avevo sette, otto anni. Sono stato interista fino al giorno in cui andai al Bentegodi e vidi Zigoni con le scarpe rosse. Da quel giorno m’innamorai del gialloblù e quell’amore, ormai a quasi 40 anni di distanza, continua ancora oggi…

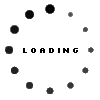
Lascia un commento