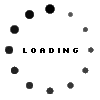Sean Sogliano vuole davvero bene al Verona. E noi vogliamo bene a lui. In un mondo che dimentica in fretta e non sa cosa sia la gratitudine, chi scrive ricorda tutto il buono che il direttore sportivo ha realizzato per l’Hellas. Ma questo non lo esenta dalle critiche. Ritengo Sogliano forse il principale responsabile del campionato del Verona. Sia chiaro, ha costruito una buona squadra sul piano tecnico e giustamente lo ha rimarcato lui stesso oggi in conferenza stampa. Tuttavia ha sbagliato molto nella gestione. Muovo dunque la stessa osservazione fatta da Vighini di recente, sebbene partendo da ragioni opposte.
Sogliano a mio avviso ha sbagliato la scelta dell’allenatore (Zanetti non andava confermato, non per demeriti o disvalore, ma per caratteristiche correlate al contesto), lo ha esonerato tardivamente e lo ha sostituito con un’opzione addirittura peggiore. Discutibile anche il ricorso ai ritiri anticipati e punitivi, che anziché unire il gruppo lo hanno innervosito. E in qualche modo hanno delegittimato e indebolito lo stesso Zanetti, che non condivideva quell’impostazione manichea nei rapporti con lo spogliatoio.
Ecco, credo che Sogliano dovrebbe evolversi e cambiare qualcosina nel suo metodo gestionale totalitario e un po’ naif. L’uomo solo al comando non può più funzionare in un calcio sempre più complesso e cosmopolita. Attenzione, Sean mica si deve snaturare, ma forse cominciare a delegare qualcosina sì. Innanzitutto andrebbe rivista la prospettiva nella scelta degli allenatori: al Verona servono uomini di personalità, autonomi, che con il ds certo si confrontano, ma che hanno totale indipendenza nelle scelte di campo. Altrimenti lo spogliatoio come fa a rispettare sul serio il tecnico di turno?
La butto lì: perché non ricominciare da figure carismatiche alla Ivan Juric? In serie B non si può sbagliare nulla se si vuole risalire immediatamente. Direte, impossibile una convivenza tra due personalità forti e passionali come Sogliano e Juric. Accolgo l’obiezione, ma rilancio: perché no? Stiamo parlando di due uomini intelligenti, ok a tratti fumantini, ma anche profondi, complessi. Potrebbe convenire al Verona, ma forse anche a entrambi: Juric, nella “sua” piazza, avrebbe l’occasione di rilanciarsi dopo un paio di annate disastrose, e imparerebbe che è pur sempre “solo” un allenatore e non tutto ruota attorno a lui; Sogliano sperimenterebbe un diverso metodo di gestione, più “politico” e manageriale, ampliando la sua visuale e acquisendo qualche nuova skill. Insomma, sarebbe una crescita per entrambi. E l’Hellas ripartirebbe da due simboli.