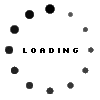Come sarebbe andata lo si era intuito fin dal principio. “Bojinov esterno d’attacco non ce lo vedo, non ha la gamba per sostenere un ruolo del genere, lui è una punta”, disse Mandorlini al “Vighini show” poche settimane dopo l’arrivo dell’attaccante bulgaro. Il tecnico ravennate, si sa, non pecca di eccessi di diplomazia e, a differenza di molti altri suoi colleghi, non occorre leggerlo troppo tra le righe per intuire ciò che pensa di Tizio piuttosto che di Caio. Aggiungiamoci altre dichiarazioni settembrine – “Cacia è intoccabile e da Gomez quest’anno mi aspetto che faccia ancora meglio. Cacia, Gomez e Bojinov assieme? Difficile” – e non è azzardato giungere alla conclusione che il bulgaro non rientrava nei piani dell’allenatore. Il quale, non è un mistero, ha accettato suo malgrado il blitz col quale Maurizio Setti l’ ha portato a Verona. E che, è acclarato, vede l’ex Fiorentina, Juve e City come terzo centravanti dopo Cacia e Cocco.
Lo stesso Bojinov, al di là dei pubblici intenti di rivalsa (“darò tutto per far ricredere l’allenatore, di cui rispetto le scelte”), è consapevole di un progetto tattico che, non dovesse mutare, è a lui estraneo. “Esterno nel 4-3-3 ho già giocato con Zeman a Lecce, ma lui concepisce questo modulo in maniera completamente diversa, gli esterni giocano più alti e hanno meno compiti di copertura rispetto a Mandorlini. Io comunque pur di giocare sono disposto ad adattarmi, anche se il mio vero ruolo è da seconda punta vicino a un altro attaccante”.
Ed è questo il nodo cruciale. Di Bojinov si può avere l’opinione che si vuole: c’è chi lo considera un ex giocatore, chi un potenziale fuoriclasse, chi sottolinea che in estate lo Sporting lo offriva a chiunque pur di piazzarlo, altri che ricordano come il talento di Gorna Ortijovah a 16 anni – all’esordio in una serie A all’epoca stellare – fece 11 gol. Io lo considero un ex campioncino che ha perso il treno per diventare campione, ma è ancora in tempo per riproporsi come ottimo giocatore. Ed è soprattutto un possibile investimento per il Verona, che a “soli” 500 mila euro ha facoltà di riscattare un giocatore che, se recuperato, può diventare il leader del Verona per i prossimi 2-3 anni, anche in serie A.
Ma, comunque la si pensi, non è questo il punto. Il nodo cruciale, dicevo, è un altro ed è lo stesso Bojinov a lasciarlo (lui sì tra le righe) intendere: se vuole sfruttarne appieno le potenzialità, Mandorlini deve cominciare a pensare a modificare l’assetto tattico del suo Verona. Sono d’accordo col mister: il tridente Gomez, Cacia e Bojinov è azzardato e anche poco logico, ma pensare a Bojinov e Cacia vicini, con Paolo Grossi (giocatore dall’enorme tecnica) a suggerire e Rivas a crossare è fantascienza? In società l’idea serpeggia e chi di dovere l’ha fatto presente. A Mandorlini l’ultima parola.