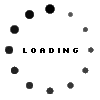“Il Verona è talmente forte che potrebbe allenarlo anche il custode dello stadio” sentenziò qualche mese fa a Sportitalia l’ex diesse Mauro Gibellini. Una sparata a salve. Un sarcasmo tendenzioso nelle intenzioni, ma innocuo nelle conseguenze, e che affermava l’ovvio: nel calcio i giocatori contano più dell’allenatore. Noi zitelle acide, anziché derubricare un’uscita del genere con una sonora risata, o con l’indifferenza, la prendemmo a male. Si sa il calcio è religione e i suoi protagonisti Dei nell’Olimpo. Così si scatenò l’inferno e montò la polemica.
Mandorlini – checché se ne dica – non è Mourinho e sprovvisto dell’ironia pungente del portoghese (“Lo Monaco chi? Io conosco Bayern Monaco, Gran Premio di Monaco, Monaco di Tibet”) si offese non poco e attaccò frontalmente il Gibo. Alcuni tifosi – i più brillanti oserei dire, e di sicuro astemi – si scatenarono sostenendo con un fine sillogismo che “Gibellini è un ubriacone perché gli piace bere” (un delitto, si sa). Come dire che una ragazza è zoccola perché le piace scopare.
Ma sono quisquillie, avrebbe detto Totò, e ognuno si tenga la propria opinione. La verità è che siamo stati tutti un po’ ottusi in questa storia. Guelfi, Ghibellini e svizzeri (nel senso di neutrali). La polemica infatti ci ha reso ciechi, in primis noi addetti ai lavori. Presi dal contestare, o dall’analizzare il match verbale Gibellini vs Mandorlini, con rispettivi tifosi al seguito, ammantati di amore verso l’uno o l’altro, gravidi di moralismo sul senso di opportunità della chiosa e della replica, abbiamo perso di vista la notizia. Il “fantasma” del custode dello stadio in realtà da tempo si annidava e aleggiava silente negli spogliatoi e anche in panchina, un po’ come Robert Redford finto carcerato in Brubaker. Salvo poi rivelarsi all’improvviso, come una verità solenne, col bottino in mano: undici punti in cinque partite. Il custode dello stadio è Bordin, ora è ufficiale. Che Gibellini lo sapesse già?