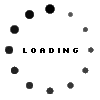Va bene va bene così, cantava Vasco. Quel pezzo era più una rassegnata e fatalistica scrollata di spalle, che un gioioso accontentarsi. Ho colto la stessa delusa rassegnazione nella parole di Mandorlini ieri in sala stampa dopo Verona-Udinese. Più che l’orgoglio per il brillante campionato della sua squadra, il tecnico mostrava rammarico per l’obiettivo sfumato dell’Europa League: “Siamo contenti per quanto fatto, ma è ancora troppo fresca la delusione, permettetemi quindi di essere un po’ così…”, il suo esordio davanti ai microfoni.
Quindi oggi anche noi scriviamo “va bene va bene così”, ma a caldo (e solo a caldo) sappiamo che va bene a metà. L’occasione era ghiotta ed è sfumata per gli episodi di Roma lunedì e qualche punto di troppo lasciato per strada.
Il “furto con scasso” (per la sua grossolanità) di Mazzoleni ancora si faceva sentire ieri in campo. Mandorlini alla fine l’ha confermato: “Se avessimo vinto a Roma, avremmo giocato con un altro spirito oggi”. Invece si è visto un Hellas scarico, come se la benzina fosse finita, arroccato sulla difensiva e a maglie larghe nella propria area di rigore. Un Verona che ha confermato quanto diciamo dall’inizio: costruito per offendere e non difendersi, dà spettacolo quando impone il suo gioco, mentre se si “abbassa” troppo prende paga, per caratteristiche e anche per il livello non eccelso dei suoi difensori.
Peccato dunque, ma resta l’orgoglio di essersi riaffermati a grandi livelli dopo tanti anni. Adesso verrà il difficile, confermarsi, ma la sfida sarà anche affascinante. Ma per il futuro c’è tempo, ora digeriamo la delusione e sorridiamo per quanto il Verona ci ha regalato. Troppi anni di retrovie, pugni nei denti e foto scolorite in soffitta, quest’anno ci siamo ripresi il palcoscenico e il voluttuoso piacere di attimi di superba gioia. Grazie Verona!
Mia pagina fb: (https://www.facebook.com/pages/Francesco-Barana/1421212388102512)